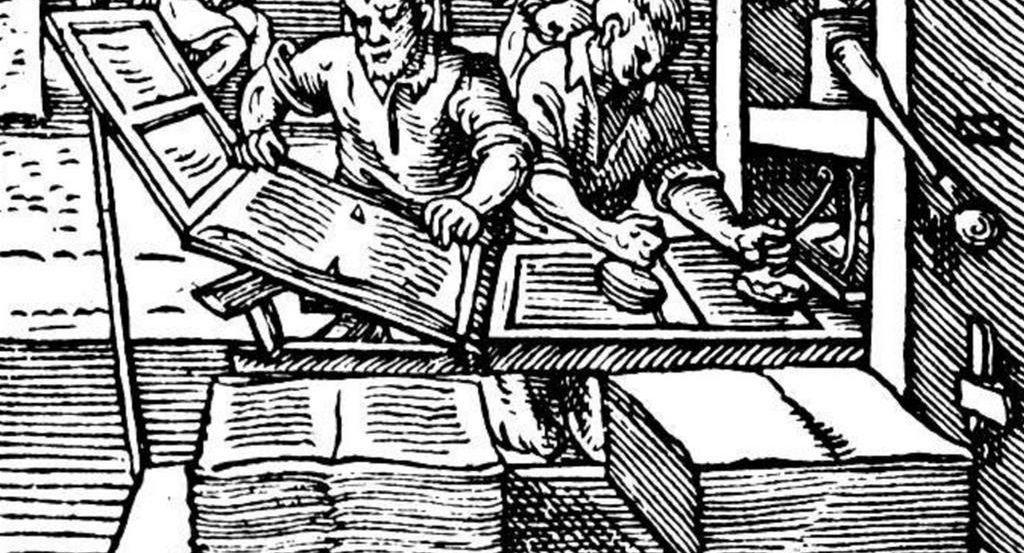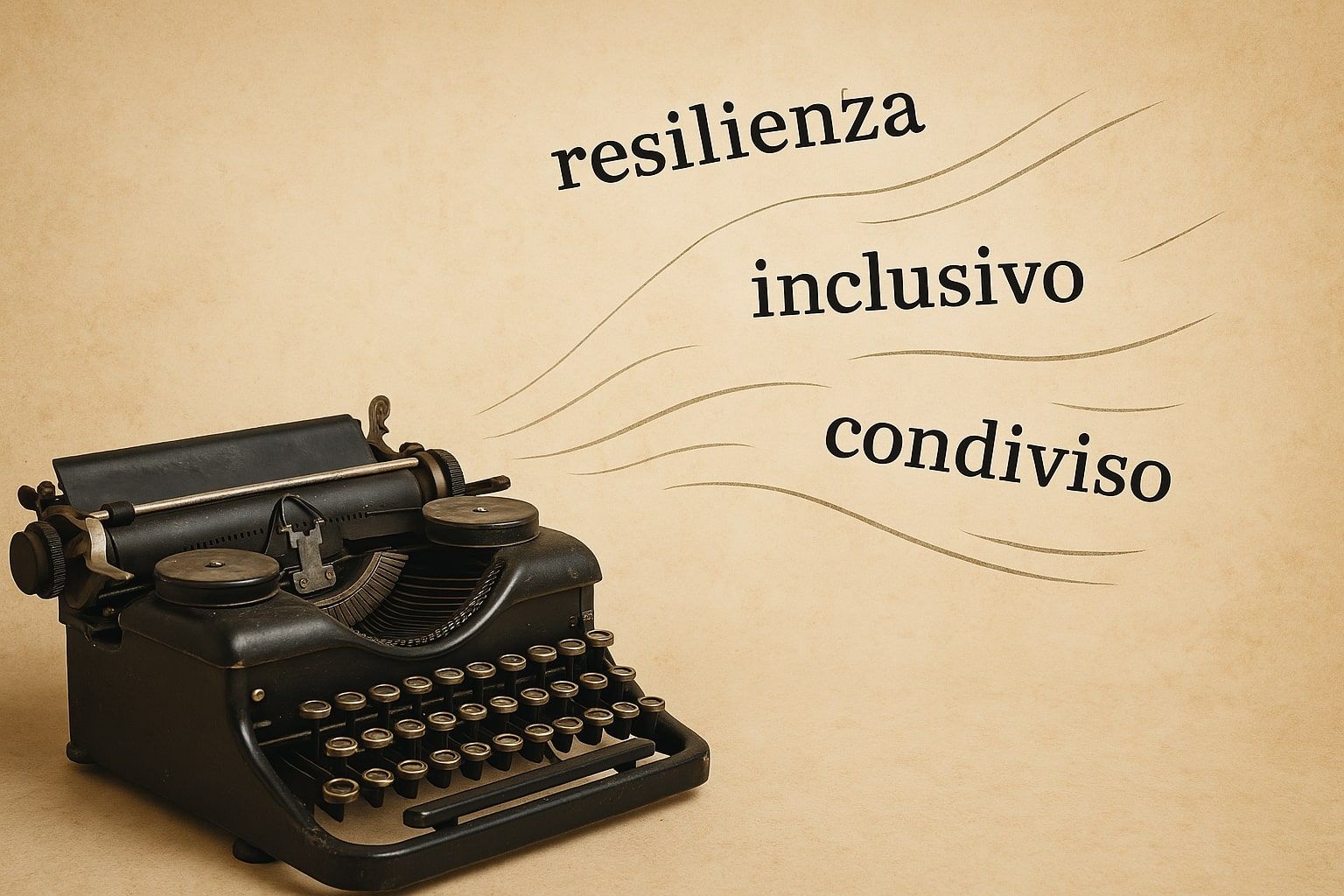Capita spesso, anche nell’epoca del computer, di sentir dire che nel nostro paese si pubblica poco e ancor meno si legge. Un giornalista straniero, alcuni anni or sono, affermava che non sarebbe stato difficile, arrivando su una spiaggia, capire se si fosse approdati in Italia o in Francia. La differenza, a suo dire, stava nel fatto che oltralpe avrebbe incontrato vacanzieri chini su un libro o su un giornale, mentre da noi giovani ed anziani erano costantemente in deambulazione sul bagnasciuga.
Eppure nella seconda metà del ‘400, quando la stampa muove i primi, seppur incerti, passi l’Italia assume velocemente il ruolo di esportatrice non solo di quelle idee che stanno a cavallo fra Umanesimo e Rinascimento, ma anche il ruolo di produttrice e distributrice di libri. Le ragioni di tale boom editoriale vanno ricercate in quelle felici concomitanze che, a volte, servono ad imporre un prodotto anche al di fuori dei confini geografici. La scoperta di Gutemberg è certamente di stampo tedesco, ma quando arriva dalle nostre parti, proprio qui trova gli elementi essenziali per svilupparsi, abbellirsi ed acquisire contenuti culturali tali che, partendo dal nostro Paese, riescono ad imporsi alla generale attenzione per scientificità di ricerca e qualità espressiva.
L’Umanesimo aveva fatto rinascere il culto del bello anche nel libro come ornamentazione, organizzazione del testo, impaginazione, formato e legatura, richiamando l’interesse per la classicità, l’amore per la ricerca e la conoscenza di quanto il passato aveva prodotto nel campo delle scienze e delle lettere. Fin dall’inizio del progetto editoriale l’Italia offre alla neonata arte tipografica l’armonia e la semplicità del carattere romano, un carattere rotondo, elaborato, derivato dalla grafia carolina dei secoli decimo e undicesimo, rimessa in voga dagli umanisti. Il tipo rotondo si contrappone subito a quello di matrice tedesca, definito gotico puro o bastardo, ormai in uso negli stati europei. I nostri tipografi allora, da un lato ingentiliscono il carattere gotico che usano prevalentemente nell’edizione di libri scientifici, mentre nelle discipline umanistiche preponderante è la presenza del carattere romano.
Pertanto è questa una delle cause che favorisce l’esportazione del libro prodotto in Italia: l’armonia e la bellezza dei caratteri usati nelle diverse edizioni. A ciò si aggiunge la facilità con la quale i tipografi riescono a procurarsi la carta. Anche in questo settore non mancano le novità. Se l’invenzione della carta va attribuita ad influenze orientali sul mondo arabo, occorre ricordare che nelle cartiere italiane, nel breve giro di pochi decenni tale prodotto ha subito enormi mutamenti. Ancor prima dell’invenzione della stampa, il nostro Paese occupa uno dei primi posti nell’esportazione della carta, molto richiesta dal mercato europeo per qualità e basso costo. L’editoria ha ora bisogno di rapidi approvvigionamenti e le cartiere di Fabriano, in primis, Mondovì, Pinerolo, Colle Valdelsa, Pescia e Faenza sono ormai all’avanguardia in questo settore.
Un’altra causa della diffusione del libro in ampie aree è legata alla lingua. La lingua latina funge ancora, nelle università e nel mondo dei dotti, da elemento indispensabile per la fruizione dell’informazione a livello europeo. I libri pertanto, in questo periodo, si avvalgono di un mercato senza confini e senza bisogno di traduzioni. Acquisito quindi un parziale vantaggio sulla concorrenza straniera i nostri tipografi non si sentono ancora arrivati: c’è infatti la possibilità di poter mettere mano, nei centri di grande cultura quali Venezia, Firenze, Roma e Napoli, su dotti studiosi provenienti dalla Grecia e da altri paesi. Si tratta di umanisti ellenici (il Masur, il Damilas, il Lascaris e altri), fuggiti da Bisanzio dopo la caduta della città, che consentono al principe dei tipografi Aldo Manuzio di stampare, per la prima volta in Europa, i classici della cultura greca nella loro lingua.
Anche Francia e Olanda avevano tentato l’esperimento però senza successo. E ancora l’Italia si segnala in questa seconda metà del XV secolo per l’avvio di alcune tipografie ebraiche che, in estrema libertà, producono volumi destinati a rinfocolare il già ricco dibattito religioso in corso.